E’ tutta,
In ogni umano stato, ozio la vita,
Se quell’oprar, quel procurar che a degno
Obbietto non intende, o che all’intento
Giunger mai non potria, ben si conviene
Ozioso nomar. (Giacomo Leopardi)
sabato 5 novembre 2011
venerdì 28 ottobre 2011
Un sonetto di Alfonso Maria Petrosino a sostegno delle educatrici precarie minacciate dai tagli del Comune di Torino
Al centro della Piazza del Palazzo
il Conte Verde impugna lo spadone,
istigando alla privatizzazione
e a darci un taglio: era un crociato, un pazzo
che bronzeo indica la via maestra.
È di sinistra il sindaco Fassino,
ma in questo modo al massimo è mancino
e quello che fa la sua mano destra
la sua sinistra non lo sa. Tiziana,
Simona, Claudia, Laura, Deborah,
nere di lutto, guidano il presidio.
Il sindaco non scende, e si allontana
da quella parte della società.
La bara è il simbolo di un omicidio.
il Conte Verde impugna lo spadone,
istigando alla privatizzazione
e a darci un taglio: era un crociato, un pazzo
che bronzeo indica la via maestra.
È di sinistra il sindaco Fassino,
ma in questo modo al massimo è mancino
e quello che fa la sua mano destra
la sua sinistra non lo sa. Tiziana,
Simona, Claudia, Laura, Deborah,
nere di lutto, guidano il presidio.
Il sindaco non scende, e si allontana
da quella parte della società.
La bara è il simbolo di un omicidio.
giovedì 27 ottobre 2011
Mia risposta a due commenti su "Ragionare con la mente estesa", su Alfabeta 2 online
Postato su Alfabeta 2
[...] è
difficile non concordare sul fatto che il medium comunicativo condizioni
i contenuti, ma da qui a concluderne che il mezzo sia il messaggio ci
vuole la genialità di McLuhann. Se rifuggiamo dall’immagine
strutturalista o postmodernista dell’individuo come nodo (o insieme di
nodi) di una rete sistemica di sensi e significati, concorderemo che a
monte di qualsiasi espressione/comunicazione c’è un’intenzione, un
soggetto pensante e incarnato, la cui intenzionalità non si lascia
comprimere completamente dal medium comunicativo (non più di quanto un
regime totalitario comprima completamente le libertà individuali:
qualcosa residua sempre).
“Interazione leggera” mi sta benissimo, se alludiamo con questo al fatto
che di norma si parte dall’assenza di interazione faccia a faccia. Il
che non giustifica i toni apocalittici sulla perdita della dimensione
fisica della relazione: certe relazioni fisiche non producono grande
socializzazione, mentre in passato si sono dati casi più che
soddisfacenti di rapporti ecsclusivamente epistolari tra illustri
ingegni (mi vengono subito in mente Gandhi e Tolstoj).
La questione del frame (suppongo in senso goffmaniano): è certamente importante, e un critico del social network ha gioco facile nell’osservare che l’assenza di corporeità costituisce un frame particolarmente asettico. Si può rispondere in molti modi: il frame non è mai assente, e allora non si vede perché dovremmo preferire i vecchi frames della comunicazione standardizzata nella società capitalista dello spettacolo integrato, (mercificata autoritaria strategica inautentica e chi più ne ha più ne disprezzi) piuttosto che una modalità “nuova” di interazione tra individui a priori reciprocamente sconosciuti, che scambiandosi frammenti testuali, immagini e segni di vario tipo possono agevolmente arrivare a conoscersi “realmente”, se ne hanno voglia e occasione.
Sul fatto che pochi interagiscano per “costruire senso” (posto che il senso si costruisca socialmente, cosa che non credo, ma intendo l’espressione come un “agire comunicativo”) non sono d’accordo: la mia esperienza personale mi dice che di senso ho provato a costruirne parecchio (ho dialogato con scrittori e politici, ho imparato e insegnato, scambiato informazioni, corretto errori, smontato stupidaggini). E a parte il mio caso personale potrei solo limitarmi a citare gli esempi più politici, come l’attuale protesta NoTav, o il Popolo Viola e il No-Berlusconi Day, l’Onda, ecc.: sono tutti casi in cui individui non precedentemente integrati in gruppi costituiti hanno potuto comunicare, organizzarsi e agire efficacemente. Mi pare che questo possa corrispondere almeno a una delle possibili definizioni di “costruzione sociale di senso”.
Certamente i social network sono diversi tra loro, e per parlarne nel dettaglio bisogna studiarli uno per uno: io mi riferivo genericamente a Facebook, che conosco e pratico più di ogni altro, e non pretendevo di considerare universale il mio modello.
Riguardo alla filosofia: non ho mai pensato che la filosofia sia sterile, al punto che cerco sempre – senza gran successo – di convincere i miei allievi a studiarla all’università. Penso però che possa essere sterile, specialmente in una prospettiva planetaria e non provinciale come la nostra, l’insegnamento della storia della filosofia, o quantomeno il vecchio dogma hegeliano-gentiliano-crociano per cui la filosofia è storia della filosofia. In questo senso l’incontro (di persona e non su Facebook…) con il filosofo Roberto Casati è stato per me fondamentale: per fare filosofia – mi disse Roberto – bisogna studiare i problemi filosofici attuali, e poi eventualmente risalire all’indietro fin dove si vuole (lui disse vent’anni…). Ti rimando al capitolo della sua recente Prima lezione di filosofia per un punto di vista non storicista , che condivido in pieno, sull’insegnamento della filosofia.
Ben vengano le “teorie dell’assurdo” (per citare un libro di Francesco Berto sui sistemi logici non classici) o la logica buddhista: sempre di logica si tratta, ossia – insisto – di una materia che nelle nostre scuole superiori non si studia normalmente. Nulla vieta di dilungarsi un po’ sul sillogismo mentre si spiega Aristotele, ma la logica moderna è tutt’altra cosa e il tempo scolastico per insegnarla io non saprei proprio dove trovarlo.
La questione del frame (suppongo in senso goffmaniano): è certamente importante, e un critico del social network ha gioco facile nell’osservare che l’assenza di corporeità costituisce un frame particolarmente asettico. Si può rispondere in molti modi: il frame non è mai assente, e allora non si vede perché dovremmo preferire i vecchi frames della comunicazione standardizzata nella società capitalista dello spettacolo integrato, (mercificata autoritaria strategica inautentica e chi più ne ha più ne disprezzi) piuttosto che una modalità “nuova” di interazione tra individui a priori reciprocamente sconosciuti, che scambiandosi frammenti testuali, immagini e segni di vario tipo possono agevolmente arrivare a conoscersi “realmente”, se ne hanno voglia e occasione.
Sul fatto che pochi interagiscano per “costruire senso” (posto che il senso si costruisca socialmente, cosa che non credo, ma intendo l’espressione come un “agire comunicativo”) non sono d’accordo: la mia esperienza personale mi dice che di senso ho provato a costruirne parecchio (ho dialogato con scrittori e politici, ho imparato e insegnato, scambiato informazioni, corretto errori, smontato stupidaggini). E a parte il mio caso personale potrei solo limitarmi a citare gli esempi più politici, come l’attuale protesta NoTav, o il Popolo Viola e il No-Berlusconi Day, l’Onda, ecc.: sono tutti casi in cui individui non precedentemente integrati in gruppi costituiti hanno potuto comunicare, organizzarsi e agire efficacemente. Mi pare che questo possa corrispondere almeno a una delle possibili definizioni di “costruzione sociale di senso”.
Certamente i social network sono diversi tra loro, e per parlarne nel dettaglio bisogna studiarli uno per uno: io mi riferivo genericamente a Facebook, che conosco e pratico più di ogni altro, e non pretendevo di considerare universale il mio modello.
Riguardo alla filosofia: non ho mai pensato che la filosofia sia sterile, al punto che cerco sempre – senza gran successo – di convincere i miei allievi a studiarla all’università. Penso però che possa essere sterile, specialmente in una prospettiva planetaria e non provinciale come la nostra, l’insegnamento della storia della filosofia, o quantomeno il vecchio dogma hegeliano-gentiliano-crociano per cui la filosofia è storia della filosofia. In questo senso l’incontro (di persona e non su Facebook…) con il filosofo Roberto Casati è stato per me fondamentale: per fare filosofia – mi disse Roberto – bisogna studiare i problemi filosofici attuali, e poi eventualmente risalire all’indietro fin dove si vuole (lui disse vent’anni…). Ti rimando al capitolo della sua recente Prima lezione di filosofia per un punto di vista non storicista , che condivido in pieno, sull’insegnamento della filosofia.
Ben vengano le “teorie dell’assurdo” (per citare un libro di Francesco Berto sui sistemi logici non classici) o la logica buddhista: sempre di logica si tratta, ossia – insisto – di una materia che nelle nostre scuole superiori non si studia normalmente. Nulla vieta di dilungarsi un po’ sul sillogismo mentre si spiega Aristotele, ma la logica moderna è tutt’altra cosa e il tempo scolastico per insegnarla io non saprei proprio dove trovarlo.
Ora rispondo anche ad Andrea (che ho costretto a leggere fin qui…):
tu mi obietti che il modello logico-argomentativo non sia mai scomparso
dalla nostra società, almeno grazie alla conversazione, ma mi pare che
tu alluda a un modello alto di conversazione, mentre se prendiamo come
esempio la conversazione calcistica (con tutto il rispetto per lo sport)
abbiamo un condensato di tutto ciò che argomentazione non è, nemmeno
nel senso di “cattiva argomentazione”: semplicemente non si adducono
argomenti, non li si concatena in modo logico, non si traggono
conseguenze e se le si traggono non ci sforza di essere coerenti con
esse. Conversazione a parte (e come dici tu, oggi anche quella è
un’esperienza in via di scomparsa) mi riferivo al fatto che le
cosiddette moltitudini siano ben poco esposte alle regole logiche
dell’argomentazione.
Da ultimo Wittgenstein, di cui ricordo, Andrea, che eri studioso in Francia: lungi da me l’idea di sminuirlo, lo considero semplicemente il filosofo più importante del Novecento (altro che Heidegger!) ma ciò non toglie che il paradigma cognitivo gli fosse necessariamente precluso, per ovvi motivi cronologici. Quindi, usare Wittgenstein contro le scienze cognitive mi pare un inutile anacronismo dato che Ludwig ha molto altro da dirci. Mi sembrerebbe insomma un po’ come usare Bruno o Bacone come antidoto alla scienza galileiana.
Tu parli di contravveleno al cognitivismo, ma io penso che il vero veleno sia proprio il postmodernismo e la sua incapacità di confrontarsi con la scienza in modo costruttivo (salve forse rare eccezioni, ma non saprei bene quali) e al di là di una generica simpatia politica che non fatico a tributargli. L’importanza della scienza cognitiva per la filosofia è per me centrale, e anche questo lo devo a Casati: nella nostra chiacchierata inaugurale mi fece rapidamente capire come proprio grazie al confronto con le scienze cognitive la filosofia sia finalmente uscita dal recinto delle intuizioni personali e della filosofia da poltrona. Ci stava comoda, la filosofia, in poltrona, ma ora i tempi stanno cambiando. E per fortuna, aggiungerei da ottimista.
Da ultimo Wittgenstein, di cui ricordo, Andrea, che eri studioso in Francia: lungi da me l’idea di sminuirlo, lo considero semplicemente il filosofo più importante del Novecento (altro che Heidegger!) ma ciò non toglie che il paradigma cognitivo gli fosse necessariamente precluso, per ovvi motivi cronologici. Quindi, usare Wittgenstein contro le scienze cognitive mi pare un inutile anacronismo dato che Ludwig ha molto altro da dirci. Mi sembrerebbe insomma un po’ come usare Bruno o Bacone come antidoto alla scienza galileiana.
Tu parli di contravveleno al cognitivismo, ma io penso che il vero veleno sia proprio il postmodernismo e la sua incapacità di confrontarsi con la scienza in modo costruttivo (salve forse rare eccezioni, ma non saprei bene quali) e al di là di una generica simpatia politica che non fatico a tributargli. L’importanza della scienza cognitiva per la filosofia è per me centrale, e anche questo lo devo a Casati: nella nostra chiacchierata inaugurale mi fece rapidamente capire come proprio grazie al confronto con le scienze cognitive la filosofia sia finalmente uscita dal recinto delle intuizioni personali e della filosofia da poltrona. Ci stava comoda, la filosofia, in poltrona, ma ora i tempi stanno cambiando. E per fortuna, aggiungerei da ottimista.
martedì 18 ottobre 2011
Pensieri sparsi sulla guerra sociale che ha luogo in Italia, 2011
Possiamo ora dirlo liberamente, poiché è finalmente venuta ad esaurimento la leggera sbornia unitarista, da festeggiarsi con bandierine tricolori e iniziative pseudoculturali maggioritariamente insulse: L'Italia è in guerra, una guerra sociale, e questo stato di guerra è sotto gli occhi di ognuno.
Per sapere che le classi sociali esistono non c'era bisogno di Marx (al limite bastava Hegel), così come oggi non c'è più alcun bisogno di riutilizzare il vecchio concetto di conflitto di classe: il proletariato industriale che Marx aveva idealizzato come "classe universale", non esiste più o forse non è mai esistito con quelle caratteristiche di omogeneità e universalità, come alcuni hanno sempre sospettato (per esempio Jacques Rancière). Ci sono classi, gruppi, settori, insiemi e soprattutto individui con proprietà sociali simili o diverse tra loro. Oggi, in Italia, gli individui e i gruppi sono attraversati tutti dallo stato di guerra sociale, che schiera due soli campi avversi.
In Occidente, la situazione di guerra sociale, che alcuni (Agamben) teorizzano ormai da anni come guerra civile planetaria, è data dalla pretesa totalitaria del capitale di sussumere tutto il sociale. I cittadini occidentali, e particolarmente quelli della repubblica italiana (in Occidente un paese-frontiera della guerra sociale planetaria) sono schierati su due virtuali campi avversi: chi detiene ricchezza, o è al suo servizio, e chi detiene scarsa o nulla ricchezza o si schiera al fianco dei nullatenenti (anche perché viene rapidamente trasformato in uno di essi).
All'interno di questi due campi le differenze sono molte e rilevanti. Ma i campi sono quelli, e in Italia l'esasperazione sociale, culturale e politica causata dal berlusconismo (più sintomo che causa della guerra sociale) li ha resi più compatti che in passato.
All'interno di questi due campi le differenze sono molte e rilevanti. Ma i campi sono quelli, e in Italia l'esasperazione sociale, culturale e politica causata dal berlusconismo (più sintomo che causa della guerra sociale) li ha resi più compatti che in passato.
Non è necessario approfondire se chi detiene ricchezze sia "capitalista" in senso marxiano, ossia se detenga realmente i mezzi di produzione, o se faccia semplicemente parte di un gruppo sociale che detiene o controlla i mezzi di produzione e dunque la produzione. E' evidente il collante materiale (postideologico) dei due campi in guerra: la ricchezza e il suo immaginario. Ogni altra ideologia sembra oggi ridotta al lumicino, inclusa quella falsamente universalistica della chiesa cattolica.
Si è parlato molto di violenza e pacifismo, negli ultimi tempi, e molto a sproposito. Qualcuno (per esempio Belpoliti) ha teorizzato (per la verità debolmente) la fine delle rivoluzioni e l'inizio dell'epoca delle rivolte. Negli ultimi mesi in Italia ci sono in effetti stati alcuni episodi di scontri violenti tra poliziotti e gruppi di "antagonisti" bellicosi.
Nota: La stessa definizione giornalistica di "antagonista" tende a maschere l'esistenza della guerra sociale. Come se chi critica anche violentemente quest'ordine sociale facesse parte di un semplice "agonismo", una leale gara tra capitale e individui.
Ora, mi pare che non si sia ancora notato che in questi scontri la violenza è sempre stata in qualche modo irregimentata. L'obiettivo dei bellicosi è sempre il solito: la distruzione fisica di obiettivi simbolici come banche e gioiellerie (centrali di spaccio del capitale e del lusso), che non può non passare per il confronto fisico con le forze di polizia, anche nel corpo a corpo. Ogni scontro vede una parte di "vincitori" e una parte di "vinti". E' qui evidentemente in gioco una dimensione simbolica, sinteticamente analizzata da Toni Negri (Il lavoro di Dioniso): la posta consiste in una momentanea vittoria o sconfitta della forza antgonista o dello Stato, simboleggiato dalle forze di polizia. Quello che sembra essere veramente in gioco è il confronto con la forza dello Stato, all'interno di una logica di confronto violento ma non radicalmente distruttivo. Nessun bellicoso ripeterebbe oggi gli slogan degli anni settanta contro lo Stato. Il problema sembra non essere più lo Stato bensì direttamente il capitale.
Tra i bellicosi vi sono anarchici e marxisti: i primi sanno di essere troppo deboli per pensare di attaccare lo stato, gli altri non vogliono distruggerlo in quanto tale ma vorrebbero uno stato privo di capitale (vogliono certamente combattere lo stato capitalista: la questione dell'abolizione dello stato è rinviata indefinitamente).
Un critico letterario neomarxista, commentando i fatti di Roma del 15 ottobre, si compiace di dichiarare "gente di merda" i bellicosi: di merda perché pensano di merda, anzi non pensano, perché non hanno una prospettiva politica.
Nella reazione del postmodernista di fronte a quella che lui chiama "estetizzazione della politica" à la Benjamin, affiora chiaramente l'esacerbato senso di impotenza personale, e di casta, che affligge l'intellettuale italiano progressista nel 2011: il sogno del comunismo si rovescia nell'incubo della violenza anarchica e ai militanti comunisti che scelgono gli scontri di piazza non viene nemmeno riservata l'ipocrisia dei "compagni che sbagliano": sono semplicemente dichiarati impolitici.
Così, l'intellettuale neomarxista prolunga la ridicola ma tragica abitudine delle scomuniche e degli anatemi comunisti: chi è nemico del Partito (oramai virtuale e conseguentemente e per l'ennesima volta sostituito non senza ansia dal "movimento") lavora per i fascisti.
Sarebbe del resto troppo facile far notare la contraddizione: accusati di "estetizzazione della politica", i blackbloc in realtà né pensano né fanno politica. Si dovrebbe dunque chiedere al critico neomarxista: CHE COSA E' dunque ciò che viene "estetizzato" da questi animali impolitici?
Chi sono, in Italia, i cosiddetti indignati che il 15 ottobre 2011 hanno fatto la loro comparsa sulla pubblica scena italiana, subito intercettati dai bellicosi?
Nota: La stessa definizione giornalistica di "antagonista" tende a maschere l'esistenza della guerra sociale. Come se chi critica anche violentemente quest'ordine sociale facesse parte di un semplice "agonismo", una leale gara tra capitale e individui.
Ora, mi pare che non si sia ancora notato che in questi scontri la violenza è sempre stata in qualche modo irregimentata. L'obiettivo dei bellicosi è sempre il solito: la distruzione fisica di obiettivi simbolici come banche e gioiellerie (centrali di spaccio del capitale e del lusso), che non può non passare per il confronto fisico con le forze di polizia, anche nel corpo a corpo. Ogni scontro vede una parte di "vincitori" e una parte di "vinti". E' qui evidentemente in gioco una dimensione simbolica, sinteticamente analizzata da Toni Negri (Il lavoro di Dioniso): la posta consiste in una momentanea vittoria o sconfitta della forza antgonista o dello Stato, simboleggiato dalle forze di polizia. Quello che sembra essere veramente in gioco è il confronto con la forza dello Stato, all'interno di una logica di confronto violento ma non radicalmente distruttivo. Nessun bellicoso ripeterebbe oggi gli slogan degli anni settanta contro lo Stato. Il problema sembra non essere più lo Stato bensì direttamente il capitale.
Tra i bellicosi vi sono anarchici e marxisti: i primi sanno di essere troppo deboli per pensare di attaccare lo stato, gli altri non vogliono distruggerlo in quanto tale ma vorrebbero uno stato privo di capitale (vogliono certamente combattere lo stato capitalista: la questione dell'abolizione dello stato è rinviata indefinitamente).
Un critico letterario neomarxista, commentando i fatti di Roma del 15 ottobre, si compiace di dichiarare "gente di merda" i bellicosi: di merda perché pensano di merda, anzi non pensano, perché non hanno una prospettiva politica.
Nella reazione del postmodernista di fronte a quella che lui chiama "estetizzazione della politica" à la Benjamin, affiora chiaramente l'esacerbato senso di impotenza personale, e di casta, che affligge l'intellettuale italiano progressista nel 2011: il sogno del comunismo si rovescia nell'incubo della violenza anarchica e ai militanti comunisti che scelgono gli scontri di piazza non viene nemmeno riservata l'ipocrisia dei "compagni che sbagliano": sono semplicemente dichiarati impolitici.
Così, l'intellettuale neomarxista prolunga la ridicola ma tragica abitudine delle scomuniche e degli anatemi comunisti: chi è nemico del Partito (oramai virtuale e conseguentemente e per l'ennesima volta sostituito non senza ansia dal "movimento") lavora per i fascisti.
Sarebbe del resto troppo facile far notare la contraddizione: accusati di "estetizzazione della politica", i blackbloc in realtà né pensano né fanno politica. Si dovrebbe dunque chiedere al critico neomarxista: CHE COSA E' dunque ciò che viene "estetizzato" da questi animali impolitici?
Chi sono, in Italia, i cosiddetti indignati che il 15 ottobre 2011 hanno fatto la loro comparsa sulla pubblica scena italiana, subito intercettati dai bellicosi?
L'etichetta deriva dal libretto di Stéphan Hessel, Indignez-vous!,
subito adottato e amplificato dai mass-media di tutto l'Occidente. (Ma
a New York l'etichetta è più diretta e tatticamente simbolica: Occupy
Wall Street).
Non è
difficile vedere che si tratta di quello che Wittgenstein avrebbe
chiamato un errore grammaticale. Il verbo "indignarsi", non tollera
sensatamente l'imperativo. Dire a qualcuno "indìgnati" non ha più senso
che dire a qualcuno "desidera!" oppure "devi volerlo!" o, in negativo:
"non pensare a un elefante rosa". Non si può indurre qualcuno a
indignarsi, come non lo si può indurre a non pensare a un elefante rosa
dopo che lo si è evocato.
Il linguaggio in molti casi non aderisce alla realtà, e questo è uno di quei casi.
Da dove viene questa esigenza di
autoetichettarsi di fronte all'opinione pubblica (a ciò che ne resta) e -
soprattutto - di fronte ai mass-media? L'impressione è che un'etichetta
confusa possa venire agitata con tanta ingenua convinzione quanto più è
debole e confuso il movimento che si riconosce in esso.
Non
stupisce che i
bellicosi prendano facilmente il sopravvento su un gruppo di persone
che si vogliono pacifiche, ma che non è detto abbiano un rapporto
sostanzioso con la teoria e la prassi della nonviolenza (ben lontana
dall'esaurirsi nel "non lanciare le pietre").
Potrebbe essere di qualche utilità la definizione che Spinoza dà dell'indignazione:
"'indignazione è odio verso qualcuno che ha fatto del male a un altro"
(Etica). Tre elementi sembrano qui essenziali: l'odio, il male commesso,
l'altro che è vittima del male.
Alcuni indignati dicono di protestare per se stessi e il proprio futuro. Questa si chiamerebbe più correttamente rabbia o ira ("cupidità da cui per odio siamo incitati a far del male a chi odiamo", sempre Spinoza). Non riesco a immaginare nessun militante di sinistra del Novecento mentre esclama la propria "indignazione" contro il capitale.
Alcuni indignati dicono di protestare per se stessi e il proprio futuro. Questa si chiamerebbe più correttamente rabbia o ira ("cupidità da cui per odio siamo incitati a far del male a chi odiamo", sempre Spinoza). Non riesco a immaginare nessun militante di sinistra del Novecento mentre esclama la propria "indignazione" contro il capitale.
La mia domanda è: perché si vuole mascherare la propria giusta rabbia sotto un'etichetta posticcia, amabigua e
di provenienza spuria (editoriale e giornalistica)? La risposta che mi
viene in mente è una sola, forse inattesa: perché SI HA PAURA DELLA
VIOLENZA SENZA CONOSCERE LA NONVIOLENZA.
La lotta NoTav è diventata una causa trasversale per tutti coloro che
la guerra sociale non vogliono subirla inermi, indignandosi a mesi
alterni e limitandosi a qualche lamentela se il tecnocrate di turno
somiglia un po' troppo all'anomalo capopolo precedentemente lasciato
governare senza contrasti.
Coloro che lottano in Val di Susa contro un'opera pubblica pensata all'insegna di un'idea di progresso che solo politici ignoranti o in malafede possono proporre senza vergogna - in realtà è finalizzata unicamente al profitto privato, per di più in totale spregio alla crisi dell'economia capitalista che il paese, l'Europa e il mondo (occidentale?) stanno attraversando - non sono uniti dall'appartenenza di classe.
Se è vero che in Valle lottano molti proletari, anarchici o comunisti più o meno bellicosi e organizzati, è altrettanto vero che aderiscono alla causa NoTav molti appartenenti alla cosiddetta "classe media" (esempio esemplare di non-concetto).
La Valle è diventata un simbolo della lotta a un capitalismo feroce e demente, che non dà frutti se non agli affaristi bipartisan, spesso se non sempre collusi con le mafie, ed elargisce qualche sparuto posto di lavoro per operai temporaneamente prelevati dall'esercito di forza-lavoro disoccupata, riserva perenne e anzi crescente che, come vide Marx, il capitalismo si guarda bene dal tentare di riassorbire.
Che la variante keynesiana del capitalismo da ultimo si rovesci storicamente in war-fare non sembra irrilevante per la guerra sociale della Val di Susa: i partiti borghesi di destra e sinistra, dopo avere affossato lo Stato che in effetti non hanno mai tenuto in gran conto, se non nella sua modalità di "stato d'eccezione", pretendono ora di dispensare squallide elemosine in forma di posti di lavoro manuale per grandi opere inutili e insostenibili. Per perseguire i loro scopi di accumulazione di profitti sono prontissimi a invocare il war-fare per una valle la cui popolazione maggioritariamente combatte ormai da anni con tutte le armi a sua disposizione.
Coloro che lottano in Val di Susa contro un'opera pubblica pensata all'insegna di un'idea di progresso che solo politici ignoranti o in malafede possono proporre senza vergogna - in realtà è finalizzata unicamente al profitto privato, per di più in totale spregio alla crisi dell'economia capitalista che il paese, l'Europa e il mondo (occidentale?) stanno attraversando - non sono uniti dall'appartenenza di classe.
Se è vero che in Valle lottano molti proletari, anarchici o comunisti più o meno bellicosi e organizzati, è altrettanto vero che aderiscono alla causa NoTav molti appartenenti alla cosiddetta "classe media" (esempio esemplare di non-concetto).
La Valle è diventata un simbolo della lotta a un capitalismo feroce e demente, che non dà frutti se non agli affaristi bipartisan, spesso se non sempre collusi con le mafie, ed elargisce qualche sparuto posto di lavoro per operai temporaneamente prelevati dall'esercito di forza-lavoro disoccupata, riserva perenne e anzi crescente che, come vide Marx, il capitalismo si guarda bene dal tentare di riassorbire.
Che la variante keynesiana del capitalismo da ultimo si rovesci storicamente in war-fare non sembra irrilevante per la guerra sociale della Val di Susa: i partiti borghesi di destra e sinistra, dopo avere affossato lo Stato che in effetti non hanno mai tenuto in gran conto, se non nella sua modalità di "stato d'eccezione", pretendono ora di dispensare squallide elemosine in forma di posti di lavoro manuale per grandi opere inutili e insostenibili. Per perseguire i loro scopi di accumulazione di profitti sono prontissimi a invocare il war-fare per una valle la cui popolazione maggioritariamente combatte ormai da anni con tutte le armi a sua disposizione.
Tra queste armi, a differenza da quelle dei politici embedded,
specialmente quelli del PD, non è affatto esclusa la nonviolenza. Il
fatto che in questa fase i bellicosi abbiano preso il sopravvento
dimostra soltanto che nessuna forza poltica ha realmente provato a
inserirsi nel dissidio tra il movimento NoTav e l'affarismo bipartisan.
I mezzi dei bellicosi sono sbagliati, anche se forse finora non del tutto controproducenti (la causa non è affatto indebolita, al contrario); ma gli affaristi che usano delle forze dell'ordine non solo usano mezzi violenti, ma li usano per fini del tutto immorali.
I mezzi dei bellicosi sono sbagliati, anche se forse finora non del tutto controproducenti (la causa non è affatto indebolita, al contrario); ma gli affaristi che usano delle forze dell'ordine non solo usano mezzi violenti, ma li usano per fini del tutto immorali.
[to be continued]
Etichette:
Agamben,
bellicosi,
Chiesa,
conflitto di classe,
guerra civile,
guerra sociale,
Hessel,
indignati,
Italia,
Marx,
nonviolenza,
NoTav,
ricchezza,
Spinoza,
Val di Susa,
violenza
giovedì 29 settembre 2011
Adieu Monsieur Novecento (Vogue32)
La
musica del Novecento ha 86 anni e attualmente il suo nome è Pierre Boulez. È
lui l'ultimo grande della Nuova Musica (etichetta che designa la musica
d’avanguardia del secondo dopoguerra), uno dei più straordinari musicisti viventi
e l'ultimo della sua generazione. La stessa di Stockhausen, Berio, Nono,
Maderna, Ligeti. Il celebrato compositore ed eccelso direttore d'orchestra sta
portando in tournée in Europa (in Italia, a Torino e a Milano, per il Festival
MITO) il suo Pli selon Pli, un astratto ritratto musicale del poeta
Mallarmé, costruito su alcuni sonetti del poeta francese.
Boulez
porta benissimo i suoi anni ed è molto emozionante vederlo dirigere con una precisione
ineguagliabile e un’energia tutta intellettuale (siamo agli antipodi della
figura del direttore romantico). La sua musica
è un misto di invenzione sublime e regole formali ferree (all’università
Boulez studiò matematica). Comunica emozioni per la sua ostentata assenza di
emozioni.
Ascoltare
oggi queste potenti e gelide composizioni per soprano e orchestra non può non
far riflettere sulla grande musica del Novecento, di cui Boulez è ormai il
glorioso superstite. La musica di Boulez (il cui “serialismo integrale” è uno
sviluppo estremo della dodecafonia di Schoenberg) ha ovviamente i suoi
detrattori. Basterebbe ricordare un articolo sardonico di Glenn Gould: “Boulez
non sarà magari un grande compositore, ma è certamente un artista interessante”
(L’ala del turbine intelligente). O
il giudizio tranchant del grande musicista
ungherese Ligeti, secondo cui la musica seriale è il frutto di un metodo dovuto
a una nevrosi compulsiva. D’altra parte un evento come la collaborazione di
Boulez con Frank Zappa, il geniale e dirompente musicista rock (ma l’etichetta
“rock” non è mai stata meno sufficiente) per il disco The Perfect Stranger, proietta
un fascio di luminosa simpatia umana sul compositore francese, da molti
considerato né più ne meno che un cervellotico dittatore (per anni ha diretto –
verrebbe da dire con pugno di ferro – l’IRCAM di Parigi, uno dei più importanti
centri di ricerca acustica e musicale al mondo).
Tornando
al concerto, l'ultimo verso di Pli selon
pli gela il sangue nelle vene: “un poco profondo ruscello calunniato la
morte”, con la parola “morte” urlata sottovoce (non so come altro dire) dal soprano
canadese Barbara Hannigan (http://www.barbarahannigan.com/).
Un gesto musicale difficilmente dimenticabile e che basterebbe a smentire
l’idea di una musica anaffettiva (quelle che scarseggiano, per non dire che
sono del tutto assenti, sono le emozioni positive…). Se Boulez, dirigendo quest'opera
grandiosa e gelida voleva farci pensare all’imminente fine, sua e del Novecento
musicale con lui, ci è riuscito perfettamente. Per fortuna la bellezza quasi aggressiva
della Hannigan, personaggio sempre più di spicco della musica contemporanea (ha
esordito recentemente anche come direttrice d'orchestra), fa da perfetto
contraltare alle emozioni cupe del concerto.
Nel
suo seducente e geometrico perfezionismo, Boulez avrà certamente calcolato
anche questo.
sabato 24 settembre 2011
Siamo tutti gay
È “giusto” che i nomi dei politici
omofobi di cui si sospetta l’orientamento omosessuale vengano inseriti in una
lista di nomi pubblicata su un blog e poi diffusa via web? Potrebbe mai essere giusto qualcosa del genere? La risposta
è ovviamente no, non c’è nulla di “giusto” in tutto questo, come in nessuna
lista di proscrizione, persecuzione politica, denigrazione pubblica di
personaggi della politica o dello spettacolo. Come in qualsiasi violenza piccola o
grande, insomma. (Ma attenzione all’argomento che in filosofia si chiama “china
pericolosa”: ad un esame attento potrebbe anche risultare ingiusto imporre
mai alcunché a chicchessia, e così si sconfinerebbe nel difficile campo morale e
politico della nonviolenza e dell’anarchismo).
Tuttavia, nel riflettere sulla
“giustezza” di una simile iniziativa non si può non tenere conto del generale e
gravissimo livello di imbarbarimento in cui l’Italia è caduta, o meglio
scivolata per una china pericolosa, non di colpo ma nel corso degli anni, a causa di alcune anomalie
politiche e sociali che sono sotto gli occhi di chiunque le voglia vedere e
abbia un minimo di strumenti culturali e morali per farlo.
Un imbarbarimento dovuto innanzitutto alla parte politica che ora viene colpita in questo modo (ma per davvero viene colpita? E quanto? I segreti di Pulcinella hanno qualche valore aggiunto se inseriti nel flusso della comunicazione mediatica?).
Un imbarbarimento dovuto innanzitutto alla parte politica che ora viene colpita in questo modo (ma per davvero viene colpita? E quanto? I segreti di Pulcinella hanno qualche valore aggiunto se inseriti nel flusso della comunicazione mediatica?).
Non che il nostro livello di
civiltà fosse esemplare, per la verità: anche limitandoci all’Italia unitaria di cui si sono
stancamente celebrati quest’anno i 150 anni, è noto che il trasformismo
politico (anticamera della corruzione) fece presto la sua comparsa nel
Parlamento post-unitario, il che contribuì a far nascere la presunta esigenza
del salvatore della Patria, notoriamente poi incarnato da un ex socialista
rivoluzionario di nome Mussolini. E il dopoguerra vide subito la penetrazione
della mafia nelle istituzioni, favorita fin dallo sbarco americano e cresciuta
fino alle dimensioni della soffocante piovra di cui Saviano ha descritto solo
l’ultima spettacolare versione, quella dell’affarismo camorristico.
Nel caso di questa lista di presunti
omosessuali omofobi (di questo si tratterebbe), la stessa comunità omosessuale
è ovviamente divisa: come può essere uno strumento di lotta per i propri diritti accusare gli
omofobi di appartenere alla stessa comunità da essi disprezzata? Che senso
politico e morale può avere questa spiata (anonima e dunque fortemente
indebolita nella sue eventuali pretese morali)?
Sarebbe bello vivere in un paese
normale, come quello evocato in un suo libro da D’Alema (uno dei politici
unanimemente accusati di aver maggiormente contribuito all’allontanarsi della
normalità): un paese cioè nel quale gli orientamenti sessuali di ciascuno non
solo non facessero notizia ma nemmeno abbisognassero di impervi iter
legislativi, regolarmente vanificati dagli “scrupoli di coscienza” di qualche
benpensante.
Sarebbe bello, ma così non è: l’Italia
non è (più e da tempo) un paese per anime pure. E come si dice in questi casi: à la guerre comme à la guerre.
mercoledì 21 settembre 2011
Bentornato, Houellebecq (vogue31)
Bentornato, Houellebecq
E'
durata poco, per fortuna, l'ansia per la presunta scomparsa di Michel
Houellebecq. Razionalista nichilista e maudit,
scrittore tra i più philosophes tra
quanti oggi abbiano un grande pubblico, Houellebecq, alias Michel Thomas, è
noto per una certa misantropia: vive in solitudine e il suo editore è abituato
a lunghi silenzi. Nei giorni scorsi tuttavia si era diffusa su internet la
notizia che lo scrittore francese, atteso ad Amsterdam e Bruxelles per un ciclo
di letture, non si era presentato e nessuno aveva sue notizie.
Così,
le scene dei suoi libri iniziavano ad affacciarsi alla mente degli appassionati
lettori (quelli che non sono appassionati lo odiano): “La testa della vittima
era intatta, mozzata di netto, posata su una poltrona davanti al caminetto; una
piccola pozza di sangue si era formata sul velluto verde scuro (…). Il resto
era un massacro, una carneficina insensata, brandelli, strisce di carne
sparpagliati sul pavimento”. Questa era la fine riservata al personaggio omonimo
dello scrittore (simile ma non identico alla persona reale) in La carta e il territorio, un bel romanzo
molto diverso dai precedenti, meno nichilista e disperato - nonostante vi si
narri di solitudine, eutanasia e assassinio - con il quale Houellebecq ha
finalmente vinto nel 2010 il premio Goncourt, uno dei più prestigiosi premi
letterari francesi.
Nelle
Particelle elementari¸ uno dei suoi
capolavori centrati sull’infelicità della condizione umana e sulla possibilità
di trionfare su di essa attraverso la tecnica (idea svolta in termini di
clonazione nel romanzo La possibilità di
un’isola, spietato visionario e lirico, forse il suo capolavoro),
descriveva sobriamente il probabile suicidio del protagonista: “Al momento
della sua scomparsa, Michel Djerzinski era unanimemente considerato un biologo
di altissima levatura, e lo si riteneva un valido candidato al Nobel; ma
l’effettiva portata della sua opera si sarebbe rivelata solo in seguito. (…)
Secondo la testimonianza delle poche persone che frequentarono Djerzinski in
Irlanda durante le sue ultime settimane, su di lui sembrava essere scesa una
sorta di rassegnazione. Il suo volto ansioso e mobile sembrava essersi
pacificato (…) Permanendo malgrado tutto il mistero intorno alla scomparsa di
Djerzinski, il fatto che il suo corpo non sia mai stato ritrovato ha finito per
alimentare una tenace leggenda secondo la quale sarebbe partito per l’Asia,
segnatamente per il Tibet, al fine di confrontare i propri lavori con certi
insegnamenti della tradizione buddista”.
Se
non proprio di una fuga in Tibet, speravamo - noi ammiratori incondizionati
dello scrittore - che si trattasse di un’assenza dovuta a ragioni futili e
passeggere: la spiegazione ufficiale parla infatti di un misunderstanding.
(Immaginiamo Houellebecq riferirisi in cuor suo all'accaduto in termini meno
diplomatici).
Certo,
è nota la sua tendenza depressiva, fulcro dell’ispirazione letteraria, e un po'
di inquietudine ci turbava. Ma non escludevamo, non fosse per la fatica e il
dubbio godimento che se ne potrebbe trarre, in una specie di capriccio
d’artista, per il divertimento di vedere quali stupidaggini si possano ancora
scrivere sul suo genio. Come quando da bambini, o per melanconia, immaginiamo
il nostro funerale e il pianto dei nostri cari per la nostra scomparsa.
Se
davvero Houellebcq non avesse mai più potuto scrivere il suo prossimo romanzo,
avremmo almeno sperato che la sua scomparsa somigliasse a quella del protagonista delle Particelle, descritta con tratti sublimi:
“Svariate testimonianze attestano la sua fascinazione per quella punta estrema
del mondo occidentale, costantemente bagnata da una luce mobile e dolce, dove
amava spingersi durante le sue passeggiate; dove, come scrive in uno dei suoi
ultimi appunti, ‘il cielo, la luce e l’acqua si confondono’. Oggi noi pensiamo
che Michel Djerzinski sia entrato nel mare”.
No,
Michel non è entrato nel mare, per fortuna, ma è sano e salvo a casa sua.
Prendere
nota per la prossima volta: ricordarsi di imparare a non prestare orecchio alle
chiacchiere della società dello spettacolo.
martedì 20 settembre 2011
Tutti sono stati bambini. Conversazione di Enrico Manera con Giuseppe Caliceti
Pubblicato su Doppiozero: Lavagna
Enrico Manera
Tutti sono stati bambini. Conversazione con Giuseppe Caliceti
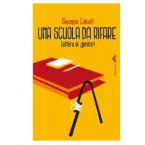
Da quando sono un insegnante ho notato che tutti gli adulti, indipendentemente dalla loro professione, quando parlano di scuola rimuovono costantemente la loro esperienza di studenti, dando giudizi di taglio vagamente sociologico che magari si appoggiano sulla vicenda dei loro figli o di adolescenti che conoscono.
Chi non lavora nella scuola – e spesso anche chi ci lavora – ha a che fare con una rappresentazione ideologica della realtà costruita dai media. Una rappresentazione che dipinge la scuola come il teatro di una catastrofe e il luogo della barbarie, con il preciso compito di servire l’attacco contro la scuola pubblica in corso da tempo, di cui i Gelmini, Brunetta, Tremonti hanno scritto solo la pagina più recente, offensiva e brutale. I problemi reali vengono sistematicamente ignorati e l’invenzione di presunte emergenze serve per legittimare provvedimenti, in genere tagli di spesa o mostruosità burocratiche inconcludenti, che creeranno nuovi problemi: in questo modo in dieci anni la condizione della scuola italiana, e la qualità della vita al suo interno, è peggiorata davvero e sistematicamente.
Il sistema culturale che ha nei media il centro di irradiazione ha rimodellato definitivamente l’economia degli affetti e del desiderio di un paio di generazioni; la scuola è stata in parte in una prima fase luogo di resistenza alla reificazione dei rapporti sociali, contro la logica economicista e contro il nuovo classismo, poi, lasciata sola, è oggi implosa su se stessa per lo sforzo immane. I docenti, sotto un attacco politico incrociato sono più stanchi, invecchiati (si veda l’età media) e a volte logorati, mentre i più giovani sono sistematicamente precarizzati; per poi essere accusati di essere il problema, come se educare gruppi di adolescenti non fosse di per sé un lavoro arduo e soprattutto come se ogni altra agenzia di socializzazione non avesse sistematicamente lavorato contro il modello educativo che trova nel sapere umanistico e scientifico il proprio vettore principale.
La cultura e l’intelligenza non interessano minimamente alla classe dirigente italiana, che al limite se ne riempie la bocca per promuovere le immagini delle aziende, o in chiave paternalistica e di prestigio per accreditare gretti localismi e al massimo pubblicizzare il turismo, secondo i cliché di lungo periodo della cultura di destra, vecchia e nuova. Così la fatica di educare è sistematicamente delegata a una scuola impotente, impoverita e sempre più fragile.
Tra i tanti libri sul tema è particolarmente significativo Una scuola da rifare (Feltrinelli, 2011) di Giuseppe Caliceti, maestro di scuola e narratore. Un libro rivolto ai genitori, che pur essendo colpiti direttamente dai tagli all’educazione, non sempre hanno presente quanto è in gioco nel berlusconismo e nelle sue ‘politiche’ rivolte all’istruzione. Del resto la stessa famiglia è al centro di una grave crisi educativa che si avvita a sua volta con cambiamenti culturali più vasti e problemi di comunicazione tra generazioni.
Caliceti ci fa sedere tra i banchi delle scuole elementari e ci racconta in episodi diversi la scuola da un punto di vista microfisico; la sua è una fenomenologia della vita quotidiana per piccoli apologhi zen, incentrata sul mondo dei bambini e che individua nuclei didattici e politici, i quali, colti nel vissuto ‘segreto’ dei nostri figli, acquistano una potenza paradigmatica e oltremodo significativa. Il suo sguardo sul mondo dell’infanzia mostra in modo più chiaro e diretto di tanti discorsi teorici i nodi problematici della nostra scuola e le loro cause.
Il libro contiene anche un manifesto per una vera rinascita della scuola che affonda le sue radici nel meglio della tradizione pedagogica italiana. “La scuola che vogliamo è: laica, gratuita, libera, solidale; in cui si sta bene insieme; che aiuti i nostri figli a diventare adulti felici e responsabili; sulla quale lo Stato sappia investire come una risorsa; che valuti l’apprendimento, ma che tenga conto anche delle emozioni; in cui i nostri figli imparino a lavorare insieme; proiettata verso il futuro; basata sul metodo delle domande e della ricerca; in cui i docenti siano preparati e si ricordino di essere stati bambini. Vogliamo una scuola senza paura di sbagliare e senza fretta: neppure di diventare grandi”. Quanto segue è una conversazione a distanza con l’autore.
Nel tuo libro mostri quanto di falso, ideologico e propagandistico ci sia nel ritorno a una mitica scuola dei bei vecchi tempi, i cui simboli sono il maestro unico e il grembiulino. Viceversa spieghi in modo semplice le ragioni della qualità della scuola pubblica italiana, prima delle riforme che avrebbero dovuto migliorarla…
Esatto. Penso infatti ci sia stato in questi tre anni una narrazione bugiarda da parte del governo di quanto è successo a scuola; d’altra parte, affermare che con tagli a fondi e docenti, tagli epocali, la qualità della scuola potesse migliorare, era senza dubbio una cosa impossibile. L’ideologia del ritorno al passato come modello per il futuro della scuola ha avuto buon gioco sui genitori degli alunni di oggi perché fa leva sul loro ricordo dell’infanzia, che però è molto diversa dall’infanzia di oggi. È un modello vecchio, anacronistico, classista, poco solidale verso chi ha più difficoltà di apprendimento: e oggi, i bambini che hanno difficoltà di questo tipo sono tanti e spesso sono anche i nostri figli, non solo quelli degli altri. Una volta un mio alunno mi ha detto che l’infanzia è quando un adulto si ricorda di essere stato bambino; non credo ci sia una definizione più efficace per esprimere ciò che per noi adulti è effettivamente l’infanzia; per i bambini, per chi la sta vivendo, invece, è tutt’altro, di tutt’altra consistenza: l’esistenza qui e ora, non un ricordo.
Mi è piaciuta molto la parte sulla valutazione e il modo in cui dai i voti. È un tema delicato anche nella scuola superiore. Colpisce l’attenzione per il mondo dei bambini e la tua denuncia dell’adultizzazione precoce a cui sono sottoposti, che spesso sono i genitori per primi ad auspicare. A questa si collegano lo spirito competitivo e l’ossessione della misurabilità.
In Occidente ci diamo molte arie per come trattiamo i bambini, in famiglia e a scuola, ma penso che ci sia ancora molta strada da fare. Il fatto è che il minore è visto – e lo dice anche la parola ‘minore’ rispetto a un presunto maggiore – come un soggetto non ancora politico, come un progetto di adulto, un prototipo. E non come una persona in fase di crescita. Una persona a tutti gli effetti. Questo comporta tutta una serie di miserie. Io invece, come del resto l’inventore degli asili più belli del mondo, Loris Malaguzzi, credo che i bambini siano portatori di una cultura altra, autonoma, completa, che sarebbe utile, in termini evolutivi e politici, anche per i genitori, per gli adulti.
A proposito di voti e di valutazione: credo ci si debba andare piano, con delicatezza, quando si valuta chi è ancora all’inizio o, comunque, all’interno di un processo educativo e di apprendimento, perché il giudizio dell’adulto, specie se negativo, incide pesantemente sul processo stesso e può creare danni enormi nei bambini e nei ragazzi.
Affronti un discorso molto interessante sulla gestione del tempo, ormai congestionato e pieno di impegni anche per i più piccoli, laddove invece tempi apparentemente morti e poco produttivi sono momenti preziosi per la vita di un gruppo; allo stesso modo una certa solitudine interiore, l’ozio ricreativo e la lentezza, importanti per la formazione dell’individuo sono scomparsi dalla vita dei ragazzi, che è ormai un flusso ininterrotto di informazioni e immagini. Penso a quando racconti del giorno in cui avete guardato la neve cadere…
Il gruppo per me è il luogo principe dell’educazione partecipata: piccolo o grande gruppo che sia. Parlare in gruppo, per esempio, non è facile per i bambini: in una classe di 25 alunni, parli una o due volte ogni 25 volte che ascolti gli altri; generalmente, è qualcosa che per un bambino – ma anche per tanti giovani adulti o adulti – è assai difficile, quasi impossibile, se non sei stato educato a farlo. Tra gruppo e momento individuale non c’è contraddizione, proprio perché parlare in gruppo significa essenzialmente ascoltare. E l’ascolto è degli altri ma anche di se stessi. Poi c’è l’altro problema del tempo libero dei bambini, e qui intendo tempo libero come tempo senza adulti, che ormai pare scomparso dall’infanzia e invece deve essere recuperato perché è fondamentale per promuovere l’autonomia di chi sta crescendo. Invece si tende a riempire di impegni continui i bambini, anche se sono impegni privi di senso e divertimento. Ricordiamoci le parole di Rodari: per sviluppare la creatività occorre anche che un bambino ogni tanto sia solo e si annoi.
Educazione al consumo e alla televisione sono obiettivi prioritari di una didattica che non sia aliena dal mondo reale. È importante che questo avvenga alle elementari, e lo dico da insegnante di liceo che si rapporta con ragazzi e ragazze il cui immaginario è quasi completamente colonizzato e sovradeterminato in senso consumistico, edonista e individualista.
L’immaginario dei bambini fino agli anni ‘70 era in mano alla Chiesa, almeno in Italia. Poi è stato lentamente colonizzato dalla televisione. Penso sia necessario e urgente, come scrivo anche nel libro, introdurre come materia di scuola la lettura e lo studio dei media. E questo ancor prima di tante altre materie che oggi sono alla moda e sembra siano più importanti: informatica o religione, inglese o altro.
Occorre tornare a spiegare bene agli studenti, ma anche ai loro genitori, che tra apprendere e informare e/o convincere a fare qualcosa, per esempio comprare un prodotto o pensarla in un certo modo, c’è una grande differenza. Mi colpisce sempre pensare alla grande quantità di soldi che il mercato spende per convincere e alle somme sempre più esigue e esangui destinate a educare e istruire: non credo sia un caso.
Un’altra cosa che sottolinei è l’attenzione rivolta all’imparare a imparare, al lavoro di gruppo e alle relazioni affettive, come precondizione per ogni compito cognitivo anche elementare. Si tratta di un’esigenza sempre più attuale, al di là delle retoriche globalizzanti legate al discorso sulla formazione permanente.
Certo. E, sottolineo, non solo quando gli studenti sono bambini, sono piccoli. Perché c’è questa leggenda: che l’importanza dell’affettività e delle relazioni affettive siano fondamentali solo nella scuola primaria; in realtà sono sempre fondamentali. E hanno a che fare col rapporto docente-studente e studente-docente: è quello il punto centrale di ogni rapporto educativo. Penso che a questo proposito siano molte le lacune dei docenti. Anche se non è tutta colpa loro. Il nostro sistema formativo è vecchio: prevede che basti conoscere e magari amare una materia, per saperla insegnare, come dicono Mastrocola e Gelmini. In realtà occorre sempre partire dalla didattica e della pedagogia. Se non si parte di lì, non si sta parlando di educazione, di scuola, ma di altre cose.
Nei tuoi allievi vedo un’anticipazione della società italiana del futuro; e anche dell’istruzione superiore alla quale sempre più figli di migranti accedono, con conseguenze rilevanti, ma sostanzialmente ignorate, su programmi e canoni culturali. Dici chiaramente che i bambini non sono razzisti e che la scuola pubblica è il vero centro della multiculturalità.
Ringrazio molto Girolamo De Michele, autore di La scuola è di tutti, per la bella recensione su “Carmilla” al mio Una scuola da rifare perché credo sia stato fino ad ora l’unico ad aver colto un aspetto per me decisivo di questo mio ultimo libro: il fatto che parlando della scuola parlassi anche della società italiana. Anche se penso che nella scuola primaria, si rispecchi ancora la parte migliore della nostra società. Spesso noi docenti, in questi anni, ci siamo trovati ad insegnare valori e contenuti esattamente opposti a quelli dei politici e dei rappresentati del governo: pensiamo alla questione immigrazione. Il fatto è che i valori costituzionali sono stati messi in discussione da questo governo in più casi. Molti docenti si sono trovati spiazzati. Non sanno più a chi dar retta. Ma la cosa più grave è stato l’attacco frontale e violento nei confronti della scuola pubblica, che è il cuore di qualsiasi democrazia. Al ministero dell’Istruzione, a parte il burattino Gelmini, abbiamo avuto “saggi” come Vittadini, gran capo dì Comunione e Liberazione e fondatore della Compagnia delle Opere: gente che è contro la scuola pubblica e a favore delle private, che vive proprio come una roba privata. Gelmini ha gridato mille volte “viva il merito”, “premiamo il merito”, ma ha fatto esattamente l’opposto con la sua controriforma: ha tolto alle scuole pubbliche italiane che i dati Ocse-Pisa del 2007 reputavano migliori delle private; e la scuola primaria italiana dal 2008 a oggi è scesa dal primo al tredicesimo posto in Europa. Di che merito parla? Tutte falsità.
Un tema sottotraccia nelle storie che racconti è la gestione del potere e il rapporto con l’autorità che tu stesso incarni agli occhi dei bambini e con il quale sembri avere un rapporto ambivalente. È qualcosa che riguarda il ruolo di ogni docente – mi ci riconosco – l’inevitabile ‘politicità’ della scuola e più in genere di ogni relazione sociale.
Il ruolo di un docente all’interno della scuola è da sempre delicato. Io credo che debba essere fondamentalmente di mediatore e ascoltatore dei bambini, di gestore il più possibile dei gruppi, di osservatore. É una sorta di antropologo che fa la spola mille volte ogni giorno tra il mondo degli adulti e il suo, tra la sua infanzia e adolescenza di un tempo e l’oggi. Non si tratta di ambivalenza, ma di equilibrio.
Infine, nel tuo discorso c’è il richiamo a non dimenticare lo ‘sguardo bambino’, dei bambini di oggi ma innanzitutto dei bambini che tutti siamo stati. Uno sguardo che potrebbe essere un buon antidoto al peggio portato dalla trasformazione antropologica che ha investito il contemporaneo.
Sì, credo che oggi si tenda a negare il bambino che siamo stati. Il bambino è visto solo come tappa, tutto è proiettato, come d’altra parte sempre accaduto, sull’adulto. Invece è fondamentale, per un docente ma anche per un semplice genitore, per qualsiasi adulto, insomma, mantenere un rapporto aperto con il proprio passato, la propria storia, il proprio essere stato bambino. Perché cambia lo stesso modo di essere adulti. In meglio.
Sillogismo triste
Da giovane avevo tanta - se non di più - voglia di scrivere quanta voglia di leggere.
Ora che ho quasi quarant'anni la voglia di scrivere mi è passata.
Mi aspetto che in vecchiaia mi passi anche la voglia di leggere.
Ora che ho quasi quarant'anni la voglia di scrivere mi è passata.
Mi aspetto che in vecchiaia mi passi anche la voglia di leggere.
domenica 18 settembre 2011
La mia memoria non è come la valanga bergsoniana
Ho una finestra mnemonica di circa 6 anni, forse perché a 6 anni ebbi il primo grosso trauma della mia vita.
Così, finché ero giovane dimenticavo di volta in volta i periodi precedenti agli ultimi 6 anni.
Ma non era grave perché ero giovane e vivevo nel presente e avevo molta vita presunta davanti a me.
Ora che invecchio, invece, è come se ricordassi con continuità soltanto gli ultimi 6 anni e il futuro non è più così promettente.
Spero che inventeranno un potente farmaco per recuperare la memoria rimossa, o me la vedo grigia.
giovedì 15 settembre 2011
Commoventi vecchi status di Facebook, 2
Oggi, nel 2010

Edoardo AcottoIl protagonista di La carte et le territoire è un pittore. L'inizio del romanzo è stranamente tranquillo...
COME INSEGNARE AI BAMBINI CHE COS'E' IL CAPITALISMO NELLA PRATICA
Ingredienti: 1) minuscoli "giardini pubblici" già privi di erba e attrezzi, in una metropoli scarsa di aree urbane verdi e attrezzate per i bambini; 2) utenza eterogenea e multiculturale, a tendenza sociale medio-bassa; 3) una ditta privata che esercita la nobile arte del profitto con i "gonfiabili" per bambini.
Preparazione: da un giorno all'altro piazzare i gonfiabili della ditta privata nei giardini pubblici, esigendo un obolo monetario per ogni bambino (teoricamente senza limite di tempo ma se c'è ressa si è tenuti a garantire l'avvicendamento).
Risultato: alcuni bambini si inebetiranno nei gonfiabili rinunciando definitivamente agli scarni giochi comunali e accanendosi a zompare ripetutamente su e giù, su e giù, su e giù, fino a che non si confonda cielo e terra, pubblico e privato, bene e male.
Esercizio: provare a frequentare per puntiglio i giardini col proprio figlio, evitando di far entrare il bimbo nei giochi privati, e spiegandogli le virtù del gioco pubblico (al limite insinuare nella mente del proprio figlio che i bimbi entrati nei gonfiabili appartengono alla classe dominante).
martedì 13 settembre 2011
Istanti di lucidità, 1
In certi momenti di opacità dell'intelletto, ci si può convincere che la persona amata ci salvi dall'angoscia per la morte, sia essa figlio o amante.
Ma basta un istante di lucidità per dissipare l'illusione e per capire che qualora si stesse per morire, l'angoscia maggiore verrebbe probabilmente dalla coscienza di dover perdere proprio la creatura amata, alla quale avevamo confidato il senso e il valore della nostra propria vita.
Buddha e Heidegger hanno ragione: non vi è autenticità o salvezza che nel Sein-zum-tode.
Ma basta un istante di lucidità per dissipare l'illusione e per capire che qualora si stesse per morire, l'angoscia maggiore verrebbe probabilmente dalla coscienza di dover perdere proprio la creatura amata, alla quale avevamo confidato il senso e il valore della nostra propria vita.
Buddha e Heidegger hanno ragione: non vi è autenticità o salvezza che nel Sein-zum-tode.
martedì 6 settembre 2011
Persone che amiamo ma che ci hanno fatto del male, 1
Franco Battiato è uno che ci ha colonizzato il cuore. Ma dove ci ha portato quell'estetica pop, quel suo pathos essoterico? Alle collaborazioni con i Subsonica? Alle sue pontificazioni sull'arte e la civiltà orientale? Che cosa ci ha insegnato, Battiato, col suo gusto (siciliano-orientale) per i fenomeni culturali più elitari e retrivi (Gurdjeff, Guénon & co.) e il suo snobismo verso la politica e le masse? Ci ha forse indicato una via per la saggezza, per la pace interiore, per la chiarezza mentale?
***
Aggiornamento 1 novembre 2013, pensando a Halloween di Carpenter: la sua pontificazione che ho odiato di più è sempre stata "ci mancavno gli idioti dell'orrore". Le sue critiche alla società contemporanea in generale sono divertenti, ma questa mi ha sempre punto sul vivo perché penso che i film horror abbiano un senso profondo (su cui non ho mai riflettuto, ma se potessi inizierei a farlo a partire dal libro di Noel Carrol, The philosophy of horror).
PS: anche l'affaire Battiato-Crocetta riposiziona Battiato in una luce favorevole, ai miei occhi. Non pensavo che riuscisse ancora ad essere così spontaneo di fronte al potere. Buono.
Iscriviti a:
Post (Atom)