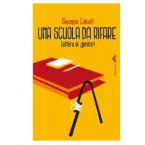Possiamo ora dirlo liberamente, poiché è finalmente venuta ad esaurimento la leggera sbornia unitarista, da festeggiarsi con bandierine tricolori e iniziative pseudoculturali maggioritariamente insulse: L'Italia è in guerra, una guerra sociale, e questo stato di guerra è sotto gli occhi di ognuno.
Per sapere che le classi sociali esistono non c'era bisogno di Marx (al limite bastava Hegel), così come oggi non c'è più alcun bisogno di riutilizzare il vecchio concetto di conflitto di classe: il proletariato industriale che Marx aveva idealizzato come "classe universale", non esiste più o forse non è mai esistito con quelle caratteristiche di omogeneità e universalità, come alcuni hanno sempre sospettato (per esempio Jacques Rancière). Ci sono classi, gruppi, settori, insiemi e soprattutto individui con proprietà sociali simili o diverse tra loro. Oggi, in Italia, gli individui e i gruppi sono attraversati tutti dallo stato di guerra sociale, che schiera due soli campi avversi.
In Occidente, la situazione di guerra sociale, che alcuni (Agamben) teorizzano ormai da anni come guerra civile planetaria, è data dalla pretesa totalitaria del capitale di sussumere tutto il sociale. I cittadini occidentali, e particolarmente quelli della repubblica italiana (in Occidente un paese-frontiera della guerra sociale planetaria) sono schierati su due virtuali campi avversi: chi detiene ricchezza, o è al suo servizio, e chi detiene scarsa o nulla ricchezza o si schiera al fianco dei nullatenenti (anche perché viene rapidamente trasformato in uno di essi).
All'interno di questi due campi le differenze sono molte e rilevanti. Ma i campi sono quelli, e in Italia l'esasperazione sociale, culturale e politica causata dal berlusconismo (più sintomo che causa della guerra sociale) li ha resi più compatti che in passato.
All'interno di questi due campi le differenze sono molte e rilevanti. Ma i campi sono quelli, e in Italia l'esasperazione sociale, culturale e politica causata dal berlusconismo (più sintomo che causa della guerra sociale) li ha resi più compatti che in passato.
Non è necessario approfondire se chi detiene ricchezze sia "capitalista" in senso marxiano, ossia se detenga realmente i mezzi di produzione, o se faccia semplicemente parte di un gruppo sociale che detiene o controlla i mezzi di produzione e dunque la produzione. E' evidente il collante materiale (postideologico) dei due campi in guerra: la ricchezza e il suo immaginario. Ogni altra ideologia sembra oggi ridotta al lumicino, inclusa quella falsamente universalistica della chiesa cattolica.
Si è parlato molto di violenza e pacifismo, negli ultimi tempi, e molto a sproposito. Qualcuno (per esempio Belpoliti) ha teorizzato (per la verità debolmente) la fine delle rivoluzioni e l'inizio dell'epoca delle rivolte. Negli ultimi mesi in Italia ci sono in effetti stati alcuni episodi di scontri violenti tra poliziotti e gruppi di "antagonisti" bellicosi.
Nota: La stessa definizione giornalistica di "antagonista" tende a maschere l'esistenza della guerra sociale. Come se chi critica anche violentemente quest'ordine sociale facesse parte di un semplice "agonismo", una leale gara tra capitale e individui.
Ora, mi pare che non si sia ancora notato che in questi scontri la violenza è sempre stata in qualche modo irregimentata. L'obiettivo dei bellicosi è sempre il solito: la distruzione fisica di obiettivi simbolici come banche e gioiellerie (centrali di spaccio del capitale e del lusso), che non può non passare per il confronto fisico con le forze di polizia, anche nel corpo a corpo. Ogni scontro vede una parte di "vincitori" e una parte di "vinti". E' qui evidentemente in gioco una dimensione simbolica, sinteticamente analizzata da Toni Negri (Il lavoro di Dioniso): la posta consiste in una momentanea vittoria o sconfitta della forza antgonista o dello Stato, simboleggiato dalle forze di polizia. Quello che sembra essere veramente in gioco è il confronto con la forza dello Stato, all'interno di una logica di confronto violento ma non radicalmente distruttivo. Nessun bellicoso ripeterebbe oggi gli slogan degli anni settanta contro lo Stato. Il problema sembra non essere più lo Stato bensì direttamente il capitale.
Tra i bellicosi vi sono anarchici e marxisti: i primi sanno di essere troppo deboli per pensare di attaccare lo stato, gli altri non vogliono distruggerlo in quanto tale ma vorrebbero uno stato privo di capitale (vogliono certamente combattere lo stato capitalista: la questione dell'abolizione dello stato è rinviata indefinitamente).
Un critico letterario neomarxista, commentando i fatti di Roma del 15 ottobre, si compiace di dichiarare "gente di merda" i bellicosi: di merda perché pensano di merda, anzi non pensano, perché non hanno una prospettiva politica.
Nella reazione del postmodernista di fronte a quella che lui chiama "estetizzazione della politica" à la Benjamin, affiora chiaramente l'esacerbato senso di impotenza personale, e di casta, che affligge l'intellettuale italiano progressista nel 2011: il sogno del comunismo si rovescia nell'incubo della violenza anarchica e ai militanti comunisti che scelgono gli scontri di piazza non viene nemmeno riservata l'ipocrisia dei "compagni che sbagliano": sono semplicemente dichiarati impolitici.
Così, l'intellettuale neomarxista prolunga la ridicola ma tragica abitudine delle scomuniche e degli anatemi comunisti: chi è nemico del Partito (oramai virtuale e conseguentemente e per l'ennesima volta sostituito non senza ansia dal "movimento") lavora per i fascisti.
Sarebbe del resto troppo facile far notare la contraddizione: accusati di "estetizzazione della politica", i blackbloc in realtà né pensano né fanno politica. Si dovrebbe dunque chiedere al critico neomarxista: CHE COSA E' dunque ciò che viene "estetizzato" da questi animali impolitici?
Chi sono, in Italia, i cosiddetti indignati che il 15 ottobre 2011 hanno fatto la loro comparsa sulla pubblica scena italiana, subito intercettati dai bellicosi?
Nota: La stessa definizione giornalistica di "antagonista" tende a maschere l'esistenza della guerra sociale. Come se chi critica anche violentemente quest'ordine sociale facesse parte di un semplice "agonismo", una leale gara tra capitale e individui.
Ora, mi pare che non si sia ancora notato che in questi scontri la violenza è sempre stata in qualche modo irregimentata. L'obiettivo dei bellicosi è sempre il solito: la distruzione fisica di obiettivi simbolici come banche e gioiellerie (centrali di spaccio del capitale e del lusso), che non può non passare per il confronto fisico con le forze di polizia, anche nel corpo a corpo. Ogni scontro vede una parte di "vincitori" e una parte di "vinti". E' qui evidentemente in gioco una dimensione simbolica, sinteticamente analizzata da Toni Negri (Il lavoro di Dioniso): la posta consiste in una momentanea vittoria o sconfitta della forza antgonista o dello Stato, simboleggiato dalle forze di polizia. Quello che sembra essere veramente in gioco è il confronto con la forza dello Stato, all'interno di una logica di confronto violento ma non radicalmente distruttivo. Nessun bellicoso ripeterebbe oggi gli slogan degli anni settanta contro lo Stato. Il problema sembra non essere più lo Stato bensì direttamente il capitale.
Tra i bellicosi vi sono anarchici e marxisti: i primi sanno di essere troppo deboli per pensare di attaccare lo stato, gli altri non vogliono distruggerlo in quanto tale ma vorrebbero uno stato privo di capitale (vogliono certamente combattere lo stato capitalista: la questione dell'abolizione dello stato è rinviata indefinitamente).
Un critico letterario neomarxista, commentando i fatti di Roma del 15 ottobre, si compiace di dichiarare "gente di merda" i bellicosi: di merda perché pensano di merda, anzi non pensano, perché non hanno una prospettiva politica.
Nella reazione del postmodernista di fronte a quella che lui chiama "estetizzazione della politica" à la Benjamin, affiora chiaramente l'esacerbato senso di impotenza personale, e di casta, che affligge l'intellettuale italiano progressista nel 2011: il sogno del comunismo si rovescia nell'incubo della violenza anarchica e ai militanti comunisti che scelgono gli scontri di piazza non viene nemmeno riservata l'ipocrisia dei "compagni che sbagliano": sono semplicemente dichiarati impolitici.
Così, l'intellettuale neomarxista prolunga la ridicola ma tragica abitudine delle scomuniche e degli anatemi comunisti: chi è nemico del Partito (oramai virtuale e conseguentemente e per l'ennesima volta sostituito non senza ansia dal "movimento") lavora per i fascisti.
Sarebbe del resto troppo facile far notare la contraddizione: accusati di "estetizzazione della politica", i blackbloc in realtà né pensano né fanno politica. Si dovrebbe dunque chiedere al critico neomarxista: CHE COSA E' dunque ciò che viene "estetizzato" da questi animali impolitici?
Chi sono, in Italia, i cosiddetti indignati che il 15 ottobre 2011 hanno fatto la loro comparsa sulla pubblica scena italiana, subito intercettati dai bellicosi?
L'etichetta deriva dal libretto di Stéphan Hessel, Indignez-vous!,
subito adottato e amplificato dai mass-media di tutto l'Occidente. (Ma
a New York l'etichetta è più diretta e tatticamente simbolica: Occupy
Wall Street).
Non è
difficile vedere che si tratta di quello che Wittgenstein avrebbe
chiamato un errore grammaticale. Il verbo "indignarsi", non tollera
sensatamente l'imperativo. Dire a qualcuno "indìgnati" non ha più senso
che dire a qualcuno "desidera!" oppure "devi volerlo!" o, in negativo:
"non pensare a un elefante rosa". Non si può indurre qualcuno a
indignarsi, come non lo si può indurre a non pensare a un elefante rosa
dopo che lo si è evocato.
Il linguaggio in molti casi non aderisce alla realtà, e questo è uno di quei casi.
Da dove viene questa esigenza di
autoetichettarsi di fronte all'opinione pubblica (a ciò che ne resta) e -
soprattutto - di fronte ai mass-media? L'impressione è che un'etichetta
confusa possa venire agitata con tanta ingenua convinzione quanto più è
debole e confuso il movimento che si riconosce in esso.
Non
stupisce che i
bellicosi prendano facilmente il sopravvento su un gruppo di persone
che si vogliono pacifiche, ma che non è detto abbiano un rapporto
sostanzioso con la teoria e la prassi della nonviolenza (ben lontana
dall'esaurirsi nel "non lanciare le pietre").
Potrebbe essere di qualche utilità la definizione che Spinoza dà dell'indignazione:
La lotta NoTav è diventata una causa trasversale per tutti coloro che
la guerra sociale non vogliono subirla inermi, indignandosi a mesi
alterni e limitandosi a qualche lamentela se il tecnocrate di turno
somiglia un po' troppo all'anomalo capopolo precedentemente lasciato
governare senza contrasti.
Coloro che lottano in Val di Susa contro un'opera pubblica pensata all'insegna di un'idea di progresso che solo politici ignoranti o in malafede possono proporre senza vergogna - in realtà è finalizzata unicamente al profitto privato, per di più in totale spregio alla crisi dell'economia capitalista che il paese, l'Europa e il mondo (occidentale?) stanno attraversando - non sono uniti dall'appartenenza di classe.
Se è vero che in Valle lottano molti proletari, anarchici o comunisti più o meno bellicosi e organizzati, è altrettanto vero che aderiscono alla causa NoTav molti appartenenti alla cosiddetta "classe media" (esempio esemplare di non-concetto).
La Valle è diventata un simbolo della lotta a un capitalismo feroce e demente, che non dà frutti se non agli affaristi bipartisan, spesso se non sempre collusi con le mafie, ed elargisce qualche sparuto posto di lavoro per operai temporaneamente prelevati dall'esercito di forza-lavoro disoccupata, riserva perenne e anzi crescente che, come vide Marx, il capitalismo si guarda bene dal tentare di riassorbire.
Che la variante keynesiana del capitalismo da ultimo si rovesci storicamente in war-fare non sembra irrilevante per la guerra sociale della Val di Susa: i partiti borghesi di destra e sinistra, dopo avere affossato lo Stato che in effetti non hanno mai tenuto in gran conto, se non nella sua modalità di "stato d'eccezione", pretendono ora di dispensare squallide elemosine in forma di posti di lavoro manuale per grandi opere inutili e insostenibili. Per perseguire i loro scopi di accumulazione di profitti sono prontissimi a invocare il war-fare per una valle la cui popolazione maggioritariamente combatte ormai da anni con tutte le armi a sua disposizione.
Coloro che lottano in Val di Susa contro un'opera pubblica pensata all'insegna di un'idea di progresso che solo politici ignoranti o in malafede possono proporre senza vergogna - in realtà è finalizzata unicamente al profitto privato, per di più in totale spregio alla crisi dell'economia capitalista che il paese, l'Europa e il mondo (occidentale?) stanno attraversando - non sono uniti dall'appartenenza di classe.
Se è vero che in Valle lottano molti proletari, anarchici o comunisti più o meno bellicosi e organizzati, è altrettanto vero che aderiscono alla causa NoTav molti appartenenti alla cosiddetta "classe media" (esempio esemplare di non-concetto).
La Valle è diventata un simbolo della lotta a un capitalismo feroce e demente, che non dà frutti se non agli affaristi bipartisan, spesso se non sempre collusi con le mafie, ed elargisce qualche sparuto posto di lavoro per operai temporaneamente prelevati dall'esercito di forza-lavoro disoccupata, riserva perenne e anzi crescente che, come vide Marx, il capitalismo si guarda bene dal tentare di riassorbire.
Che la variante keynesiana del capitalismo da ultimo si rovesci storicamente in war-fare non sembra irrilevante per la guerra sociale della Val di Susa: i partiti borghesi di destra e sinistra, dopo avere affossato lo Stato che in effetti non hanno mai tenuto in gran conto, se non nella sua modalità di "stato d'eccezione", pretendono ora di dispensare squallide elemosine in forma di posti di lavoro manuale per grandi opere inutili e insostenibili. Per perseguire i loro scopi di accumulazione di profitti sono prontissimi a invocare il war-fare per una valle la cui popolazione maggioritariamente combatte ormai da anni con tutte le armi a sua disposizione.
Tra queste armi, a differenza da quelle dei politici embedded,
specialmente quelli del PD, non è affatto esclusa la nonviolenza. Il
fatto che in questa fase i bellicosi abbiano preso il sopravvento
dimostra soltanto che nessuna forza poltica ha realmente provato a
inserirsi nel dissidio tra il movimento NoTav e l'affarismo bipartisan.
I mezzi dei bellicosi sono sbagliati, anche se forse finora non del tutto controproducenti (la causa non è affatto indebolita, al contrario); ma gli affaristi che usano delle forze dell'ordine non solo usano mezzi violenti, ma li usano per fini del tutto immorali.
I mezzi dei bellicosi sono sbagliati, anche se forse finora non del tutto controproducenti (la causa non è affatto indebolita, al contrario); ma gli affaristi che usano delle forze dell'ordine non solo usano mezzi violenti, ma li usano per fini del tutto immorali.
[to be continued]